Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente.
Febbraio 2022Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente.
Note a cura di Gustav Ida.
1.L’8 febbraio 2022 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente una proposta di legge (A.C. 3156), volta ad inserire la tutela dell’ambiente tra i princìpi fondamentali della Costituzione. Il 19 gennaio 2022 la I Commissione della Camera dei deputati aveva concluso l’esame, in seconda lettura, del testo che introduce un nuovo comma all’articolo 9 della Costituzione, al fine di riconoscere -nell’ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione- il principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.
1.1.Con le suddette integrazioni del testo costituzionale si attribuisce alla Repubblica, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma dell’art. 9 Cost., anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Viene inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.
Viene al contempo modificato l’articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell’iniziativa economica. In primo luogo, si interviene sul secondo comma stabilendo che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana.
Un’importante modifica riguarda il terzo comma dell’articolo 41, che riserva alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.
Finalità delle modifiche, come evidenziato nel corso dei lavori parlamentari, è in primo luogo quella di dare articolazione al principio della tutela ambientale, ulteriore rispetto alla menzione della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” previsto dall’articolo 117, secondo comma della Costituzione -introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001– nella parte in cui enumera le materie su cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva.
Accanto a quella dell’ambiente, si attribuisce alla Repubblica la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. In tale ambito, viene introdotto un riferimento all'”interesse delle future generazioni”, espressione utilizzata per la prima volta nel testo costituzionale.
L’ambiente è qui inteso nella sua accezione più estesa e sistemica: quale ambiente, ecosistema, biodiversità.
La formulazione dà svolgimento e sviluppo ad orientamenti di tutela affermati dalla Corte costituzionale in via interpretativa, espressi in base alle disposizioni costituzionali vigenti.
La tutela degli ecosistemi richiama la competenza legislativa dello Stato, di cui alla lettera s) del secondo comma dell’articolo 117.
In particolare, la tutela del “paesaggio” costituzionalmente sancita dall’articolo 9 è stata declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura ‘espansiva’.
In tale prospettiva l’ambiente si configura non come mero bene o materia competenziale bensì come valore primario e sistemico.
Come noto, la Corte ha fatto riferimento (nella sentenza n. 179 del 2019) ad un “processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l’ambiente che la circonda, all’interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo [di questo si trattava, in quel giudizio, ndr.] quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell’equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale”.
“In questa prospettiva la cura del paesaggio riguarda l’intero territorio, anche quando degradato o apparentemente privo di pregio” -aggiunge la sentenza n. 71 del 2020- la quale sottolinea altresì che “la tutela paesistico-ambientale non è più una disciplina confinata nell’ambito nazionale”, soprattutto in considerazione della Convenzione europea del paesaggio (adottata a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 luglio 2000 e ratificata in Italia con legge n. 14 del 2006), secondo la quale “il concetto di tutela collega indissolubilmente la gestione del territorio all’apporto delle popolazioni” (donde “il passaggio da una tutela meramente conservativa alla necessità di valorizzare gli interessi pubblici e delle collettività locali con interventi articolati”, tra i quali, in quel caso, l’acquisizione e il recupero delle terre degradate).
Su questa evoluzione interpretativa della tutela, da paesaggistica (dunque morfologica, visiva, culturale) ad ambientale (costitutiva, valoriale, comunitaria), è intervenuta altresì la riforma del Titolo V, modificativa dell’articolo 117, secondo comma della Costituzione.
In tale ambito è stata introdotta la previsione della “tutela” dell’ambiente e dell’ecosistema, tra le materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (con attribuzione invece della “valorizzazione” dei beni ambientali alla potestà concorrente delle Regioni).
La Corte ha avuto modo di ribadire in proposito (con la sentenza n. 407 del 2002) come “l’evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una ‘materia’ in senso tecnico, qualificabile come ‘tutela dell’ambiente’, dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze”. Donde “una configurazione dell’ambiente come ‘valore’ costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia ‘trasversale’, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale”.
L’ambiente come valore costituzionalmente protetto (e come entità organica complessa: sentenza n. 378 del 2007) fuoriesce da una visuale esclusivamente ‘antropocentrica’. Nella formulazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), ambiente ed ecosistema non si risolvono in un’endiadi, in quanto, “col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l’habitat degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé” (sentenza n. 12 del 2009).
1.2. La proposta di legge costituzionale approvata si compone di tre articoli.
Art. 1. “All’articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
Art. 2.”All’articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all’ambiente,»; b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».
Art. 3. ”La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all’ articolo 9 della Costituzione, come modificato dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti”.
1.3. L’articolo 1 introduce un nuovo comma all’articolo 9, al fine di riconoscere nell’ambito dei Principi fondamentali enunciati nella Costituzione un principio di tutela ambientale. Pertanto, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Viene infine inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.
L’articolo 2 modifica l’articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell’iniziativa economica. In primo luogo, interviene sul secondo comma e stabilisce che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica investe, invece, il terzo comma dell’articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.
L’articolo 3 reca una clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2.Articolo 1: Modifica dell’art. 9 della Costituzione. L’articolo 1 aggiunge un comma all’articolo 9 della Costituzione, che al secondo comma già riconosce quale compito della Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. Il nuovo terzo comma è specificamente dedicato ai profili ambientali ed è suddiviso in due periodi. Finalità della modifica (come si evince dai lavori parlamentari), è in primo luogo quella di dare articolazione al principio della tutela ambientale, ulteriore rispetto alla menzione della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” previsto dall’articolo 117, secondo comma della Costituzione – introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001 – nella parte in cui enumera le materie su cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva. Al primo periodo, accanto a quella dell’ambiente, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela della biodiversità e degli ecosistemi.
Sempre al primo periodo, viene introdotto un riferimento espresso all’ “interesse delle future generazioni”, espressione inedita nel testo costituzionale.
L’ambiente è qui inteso nella sua accezione più estesa e ‘sistemica’: quale ambiente, ecosistema, biodiversità. La formulazione dà svolgimento e sviluppo ad orientamenti di tutela affermati dalla Corte costituzionale in via interpretativa, allorché rilevassero ai fini delle disposizioni costituzionali vigenti. La tutela degli ecosistemi richiama la competenza legislativa dello Stato, di cui alla lettera s) del secondo comma dell’articolo 117. In particolare, la tutela del “paesaggio” costituzionalmente sancita dall’articolo 9 è stata declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura ‘espansiva’. In tale prospettiva l’ambiente si configura non come mero bene o materia competenziale bensì come valore primario e sistemico. La Corte ha altresì fatto riferimento (nella sentenza n. 179 del 2019) ad un “processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l’ambiente che la circonda, all’interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell’equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale”. “In questa prospettiva la cura del paesaggio riguarda l’intero territorio, anche quando degradato o apparentemente privo di pregio”, aggiunge la sentenza n. 71 del 2020 – la quale sottolinea altresì che “la tutela paesistico-ambientale non è più una disciplina confinata nell’ambito nazionale”, soprattutto in considerazione della Convenzione europea del paesaggio (adottata a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 luglio 2000 e ratificata con legge n. 14 del 2006), secondo la quale “il concetto di tutela collega indissolubilmente la gestione del territorio all’apporto delle popolazioni” (donde “il passaggio da una tutela meramente conservativa alla necessità di valorizzare gli interessi pubblici e delle collettività locali con interventi articolati”, tra i quali, in quel caso, l’acquisizione e il recupero delle terre degradate). Su questa evoluzione interpretativa della tutela, da paesaggistica (dunque morfologica, visiva, culturale) ad ambientale (costitutiva, valoriale, comunitaria), è intervenuta altresì la riforma del Titolo V, modificativa dell’articolo 117, secondo comma della Costituzione. In tale ambito è stata introdotta la previsione della “tutela” dell’ambiente e dell’ecosistema, tra le materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (con attribuzione invece della “valorizzazione” dei beni ambientali alla potestà concorrente delle Regioni).
La Corte ha avuto modo di ribadire in proposito (con la sentenza n. 407 del 2002) come “l’evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una ‘materia’ in senso tecnico, qualificabile come ‘tutela dell’ambiente’, dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze”. Donde “una configurazione dell’ambiente come ‘valore’ costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia ‘trasversale’, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale”.
L’ambiente come valore costituzionalmente protetto (e come entità organica complessa: sentenza n. 378 del 2007) fuoriesce da una visuale esclusivamente ‘antropocentrica’. Nella formulazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), ambiente ed ecosistema non si risolvono in un’endiadi, in quanto, “col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l’habitat degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé” (sentenza n. 12 del 2009).
In questa più ampia prospettiva si pone il secondo periodo del comma aggiuntivo previsto dalla proposta di legge costituzionale che ha ad oggetto la tutela degli animali, attraverso l’introduzione di una riserva di legge statale che ne disciplini forme e modi.
Per la prima volta viene introdotto nella Costituzione il riferimento agli animali, prevedendo una legge che ne definisca le forme e i modi di tutela. Nel corso della discussione parlamentare il dibattito ha investito anche diverse possibili formulazioni quali la proposta di inserimento di una tutela degli animali quali “esseri senzienti” (riprendendo una dicitura presente nell’articolo 13 del Trattato di Lisbona dell’Unione europea) o di contro l’opzione di non inserimento alcuno di una previsione circa la tutela gli animali, ritenuta già inclusa appieno nella nozione di ecosistema e biodiversità quale scandita dalla novella.
3.Articolo 2: Modifica dell’art. 41 della Costituzione. Con una prima modifica (lettera a)), si interviene sul secondo comma dell’articolo 41 Cost., aggiungendo all’attuale previsione – in base alla quale l’iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana– l’ulteriore vincolo che essa non possa svolgersi in modo tale da recare danno alla salute e all’ambiente. Si ricorda che l’articolo 41 stabilisce che l’iniziativa economica privata è libera (primo comma). In base al testo vigente, essa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (comma secondo).
Le relazioni ai progetti di legge costituzionale sottolineano come, premettendo questi ulteriori due limiti a quelli, già vigenti, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, si è inteso dare sostanza al nuovo dettato dell’articolo 9, elevando al rango costituzionale princìpi già previsti dalle norme ordinarie e affiancando altresì la salute all’ambiente per la stretta correlazione tra i due aspetti.
Con altra modifica (lettera b)), si prevede l’aggiunta, al terzo comma dell’articolo 41, della possibile destinazione e coordinamento dell’attività economica pubblica e privata anche ai fini ambientali. In base al testo vigente del comma terzo dell’articolo 41 Cost., la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Con la modifica prevista viene dunque aggiunto, a tale previsione, il riferimento ai fini ambientali accanto a quelli sociali.
4.L’articolo 3 reca una clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Come noto, l’espressione “legge dello Stato” ricorre nella Costituzione esclusivamente nel Titolo V della sua Parte II, relativo ai rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali. Nelle disposizioni concernenti i principi fondamentali, così come nei quattro Titoli che compongono la Parte I e nei Titoli I, II, III, IV e VI che compongono la Parte II della Costituzione, figura, ove compaia, l’espressione “legge”.
A sua volta, l’articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione riserva la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Tuttavia la Corte costituzionale, nella definizione dell’assetto delle competenze tracciato dal riformato Titolo V, ha chiarito più profili riguardo a tale riparto, tali da rendere più articolato il quadro (e richiamare il principio di leale collaborazione).
Secondo la Corte (sentenza n. 536 del 2002), l’ambiente come valore costituzionalmente protetto “non esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie (governo del territorio, tutela della salute, ecc.) per le quali quel valore costituzionale assume rilievo (sentenza n. 407 del 2002)”.
Da un lato dunque, “in funzione di quel valore, lo Stato può dettare standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex articolo 117 della Costituzione” (ha rilevato la sentenza ultima citata); e tale disciplina legislativa statale di tutela agisce come “limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato” (sentenza n. 378 del 2007). Tale limite vale anche per le Regioni ad autonomia speciale, per le quali la disciplina statale di tutela ambientale è da ritenersi espressione di riforme economiche-sociali (cfr. la sentenza n. 51/2006).
Dall’altro lato, la ‘trasversalità’ dell’ambiente legittima interventi normativi delle Regioni le quali, nell’esercizio delle loro competenze, curino interessi all’ambiente funzionalmente collegati, ancorché si tratti di un esercizio regionale ‘condizionato’, ossia tenuto a non diminuire la tutela ambientale stabilita dallo Stato. Come ha evidenziato la corte nella sentenza n. 63/2020, la normativa regionale “deve garantire il rispetto dei livelli minimi uniformi posti dal legislatore nazionale in materia ambientale”. “L’esercizio della competenza legislativa regionale, dunque, trova un limite nella disciplina statale della tutela ambientale, salva la facoltà delle Regioni di prescrivere livelli di tutela ambientale più elevati di quelli previsti dallo Stato”.
La sentenza n. 88/2020 ha ribadito che “in materia ambientale, il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale è riservato allo Stato, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali”. Quanto ai suddetti interventi regionali, “la Corte ha affermato che la collocazione della materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» tra quelle di esclusiva competenza statale non comporta che la disciplina statale vincoli in ogni caso l’autonomia delle Regioni, poiché il carattere trasversale della materia, e quindi la sua potenzialità di estendersi anche nell’ambito delle competenze regionali, mantiene salva la facoltà delle Regioni di adottare, nell’esercizio delle loro competenze legislative, norme di tutela più elevate”.
5.La giurisprudenza costituzionale sul rapporto tra iniziativa economica e ambiente. La Corte costituzionale si è pronunciata sul rapporto tra il diritto costituzionalmente tutelato dall’articolo 41 della Costituzione e altri diritti costituzionalmente rilevanti, anche con riferimento ai profili dell’ambiente e della salute.
Con la sentenza n. 58/2018, in riferimento alla materia dell’industria e degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, la Corte costituzionale ha affrontato il tema dei vincoli all’iniziativa economica, concernenti la vicenda delle acciaierie Ilva di Taranto, dopo la pronuncia della nota sentenza n. 85 del 2013 (su cui infra). Già nella sentenza n. 182 del 2017 la Corte aveva vagliato la legittimità di uno dei numerosi “decreti Ilva” (il d.l. 98/2016, conv. in l. 151/2016), respingendo il ricorso della Regione Puglia volto a censurare la carenza di adeguate forme di partecipazione della medesima alla revisione del “Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria” di cui al d.l. 61/2013 (conv. in l. 89/2013). Nella decisione, come in quelle precedenti, è al centro dell’attenzione il bilanciamento tra beni e diritti costituzionali, in particolare, in questo caso, iniziativa economica, lavoro e salute; con la pronuncia veniva sottolineato come non potesse ritenersi astrattamente precluso al legislatore di intervenire per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l’economia nazionale (e per garantire i correlati livelli di occupazione).
La Corte è stata chiamata a giudicare la legittimità costituzionale del cd. “decreto Ilva” del 2015 (art. 3 del dl n. 92 del 2015, abrogato e riprodotto in maniera identica, come osserva la stessa Corte, dal dl n. 83 del 2015), il quale consente la prosecuzione dell’attività dell’Ilva nonostante il provvedimento di sequestro preventivo dell’autorità giudiziaria per reati inerenti alla sicurezza dei lavoratori, con una motivazione che ricalcava la cit. sentenza del 2013: per «garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva, di salvaguardia dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente salubre, nonché della finalità di giustizia, l’esercizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interessi strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro (…) quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori», purché -come puntualizza la Corte- venga predisposto entro un mese un «piano ad opera della stessa parte privata colpita dal sequestro dell’autorità giudiziaria, senza alcuna forma di partecipazione di altri soggetti pubblici o privati». Come osserva la Corte, il legislatore concede un termine di trenta giorni per la predisposizione del piano, il quale peraltro può anche essere provvisorio: dunque, manca del tutto la richiesta di misure immediate e tempestive atte a rimuovere prontamente la situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori. Tale mancanza è tanto più grave in considerazione del fatto che durante la pendenza del termine è espressamente consentita la prosecuzione dell’attività d’impresa “senza soluzione di continuità”, sicché anche gli impianti sottoposti a sequestro preventivo possono continuare ad operare senza modifiche in attesa della predisposizione del piano e, quindi, senza che neppure il piano sia adottato.
Come noto, il caso dello stabilimento dell’Ilva di Taranto aveva visto l’adozione di previsioni legislative in base a cui -anche in presenza di sequestri preventivi disposti dall’autorità giudiziaria nel corso di processi penali- non risultava impedita la prosecuzione dell’attività d’impresa, purché a tale previsione pervenisse attraverso un ragionevole ed equilibrato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco. Secondo la giurisprudenza costituzionale, tale bilanciamento dev’essere condotto ‘senza consentire l’illimitata espansione di uno dei diritti’, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.
A tale riguardo La Corte ha affermato come il bilanciamento debba rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati (in tal senso si v. la sentenza n. 85/2013, già richiamata; e le sentenze n. 63/2016 e n. 264/2012). “Appare chiaro -conclude la Corte nella suddetta pronuncia- che, a differenza di quanto avvenuto nel 2012, il legislatore ha finito col privilegiare in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (art. 4 e 35 Cost.). Il sacrificio di tali fondamentali valori tutelati dalla Costituzione porta a ritenere che la normativa impugnata non rispetti i limiti che la Costituzione impone all’attività d’impresa la quale, ai sensi dell’art. 41 Cost., si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l’incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l’attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona”.
Più analiticamente, con la pronuncia n. 58/2018 la Corte (nel dichiarare costituzionalmente illegittime talune disposizioni volte a consentire la prosecuzione per dodici mesi dell’attività produttiva di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale sottoposti a sequestro preventivo disposto dall’autorità giudiziaria in relazione a ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori, -nella fattispecie l’altoforno “Afo2” ILVA di Taranto-) ravvisava la violazione delle disposizioni costituzionali di cui agli articoli 2, 4, 32, primo comma, 35, primo comma, nonché dell’articolo 41 secondo comma, Cost. La normativa censurata veniva ritenuta ‘lungi dal bilanciare in modo ragionevole e proporzionato tutti gli interessi costituzionali rilevanti’; essa, bensì, veniva rilevata tale da “privilegiare in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.)”. A tali diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa deve, secondo quanto rilevato dalla Corte, ritenersi inscindibilmente connesso lo stesso diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (artt. 4 e 35 Cost.), per cui le previsioni legislative oggetto di censura integravano una violazione dei limiti all’attività d’impresa, la quale- sottolinea la Corte – “ai sensi dell’art. 41 Cost., si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
In tal senso, in base a quanto già enucleato dalla giurisprudenza costituzionale, rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l’incolumità e la vita dei lavoratori costituisce condizione minima e indispensabile perché l’attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona.
Nel caso di specie, il quadro legislativo censurato (dal GIP del Tribunale di Taranto), diversamente da quanto previsto dalla normativa già scrutinata dalla citata sentenza n. 85/2013 della Corte costituzionale, non richiedeva misure immediate e tempestive atte a rimuovere prontamente la situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori, bensì ‘subordinava la prosecuzione dell’attività d’impresa esclusivamente alla predisposizione, entro trenta giorni, di un piano, anche provvisorio, formato unilateralmente dalla stessa parte privata colpita dal sequestro, contenente misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, non meglio definite né verificabili nella loro effettiva incidenza’.
Secondo la giurisprudenza costituzionale in parola, le norme di cui agli artt. 32 e 41 Cost. impongono -nel quadro costituzionale vigente- la massima attenzione per la protezione della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, prefigurando dei limiti alla tutela dell’iniziativa economica privata, enucleandosi così già dei limiti alla tutela dell’iniziativa economica privata, in ragione di una ‘tenuta sistemica’ dei diritti costituzionali in rilievo.
Nella precedente sentenza sull’Ilva, la n. 85/2013, la Corte aveva risolto il conflitto tra diritti parlando di «un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all’ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso», precisando, subito dopo, che «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri.
Già in base a tale pronuncia, si afferma come la tutela debba essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro”: se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che, come già anticipato, diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona». Occorre, invece, secondo la Corte, garantire un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. Nella pronuncia di allora, la qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto.
Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato -dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo- secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale.
Come già anticipato, con la sentenza n. 85/2013 la Corte evidenziava come la combinazione tra un atto amministrativo rilevante ai fini ambientali, quale l’AIA, da un lato, e una previsione legislativa (l’art. 1 del d.l. n. 207 del 2012) determinasse condizioni e limiti della liceità della prosecuzione di un’attività produttiva per un tempo definito; la fattispecie concerneva tutti i casi in cui uno stabilimento dichiarato di interesse strategico nazionale avesse procurato inquinamento dell’ambiente (al punto da provocare, nel caso di specie, l’intervento cautelare dell’autorità giudiziaria).
Tale combinazione sta -rileva la pronuncia citata- nel non prevedere la norma legislativa una pura e semplice continuazione dell’attività economica, alle medesime condizioni che avevano reso necessario l’intervento repressivo dell’autorità giudiziaria, ma nell’imporre delle nuove condizioni, la cui osservanza sia oggetto di un continuo controllo: “con tutte le conseguenze giuridiche previste in generale dalle leggi vigenti per i comportamenti illecitamente lesivi della salute e dell’ambiente”. Il suddetto quadro previsionale veniva, perciò, anche ritenuto ispirato alla finalità di attuare un non irragionevole bilanciamento tra i princìpi della tutela della salute e dell’occupazione, e non al totale annientamento del primo. La Corte anche qui evidenziava come tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovino in rapporto di integrazione reciproca, non risultando possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri, bensì delineandosi una tutela che deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro», pena l’illimitata ‘espansione di uno dei diritti, che diverrebbe,come già anticipato, “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette’, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.
La Corte precisava allora come, in tale quadro, non si potesse condividere l’assunto (dell’allora rimettente giudice per le indagini preliminari) secondo cui l’aggettivo «fondamentale», contenuto nell’art. 32 Cost., sarebbe rivelatore di un «carattere preminente» del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona. Né, affermava la Corte, la definizione data dalla giurisprudenza costituzionale dell’ambiente e della salute come «valori primari» – in base alla sentenza n. 365 del 1993- implica una “rigida” gerarchia tra diritti fondamentali.
La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi.
La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che “gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. La giurisprudenza costituzionale, nel quadro delle norme costituzionali vigenti, evidenzia un ‘punto di equilibrio’, dinamico e non prefissato in anticipo, che deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali, come ricordato, da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale.
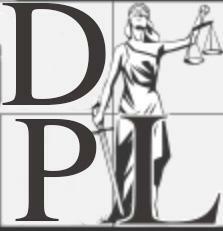
Commenti recenti