Il Ministero del Lavoro, con la Circolare 18 aprile 2025, n. 9 (di cui pubblichiamo qui di seguito il testo) , fornisce indicazioni per una ricognizione delle effettive modalità attraverso le quali è resa l’attività lavorativa nel settore dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali, tenendo conto della necessità di garantire ai lavoratori un adeguato contenuto di tutela, a prescindere dalla forma contrattuale con la quale è stipulato il rapporto di lavoro, pur nella consapevolezza della insufficienza dei tentativi di esclusiva riconduzione forzosa al rapporto di lavoro subordinato. La contrattazione collettiva appare essere lo strumento con il quale dare corretta attuazione alla disciplina legislativa e così evitare utilizzi distorti della stessa.
“MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI. Circolare 18 aprile 2025, n. 9.
Classificazione e tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali
Con la presente nota si intendono fornire indicazioni che, a legislazione vigente, possano risultare utili per una ricognizione, quanto più possibile puntuale, delle effettive modalità attraverso le quali è resa l’attività lavorativa del settore in oggetto, tenendo conto della necessità di garantire, in ogni caso, ai lavoratori, un adeguato contenuto di tutela, a prescindere dalla tipologia contrattuale con la quale è stipulato il rapporto di lavoro, nella consapevolezza della insufficienza dei tentativi di esclusiva riconduzione forzosa al rapporto di lavoro subordinato.
La prestazione resa dai lavoratori per il tramite delle piattaforme digitali può essere organizzata, così come ogni altra attività lavorativa, con modalità tra loro anche significativamente differenti. La stessa categoria dei lavoratori che rendono tale attività non si esaurisce esclusivamente con coloro che provvedono alla consegna di beni per conto altrui, sebbene quella dei ciclofattorini (o riders) rappresenti oggettivamente la modalità con la maggiore diffusione, nell’ambito della ricognizione offerta dal d.lgs. n. 81/2015.
Dal punto di vista normativo, alla disciplina interna (art. 2 e Capo V-bis del d.lgs. n. 81/2015), si è aggiunta la recente Direttiva (UE) 2024/2831, relativa al lavoro mediante piattaforme digitali, adottata il 24 ottobre 2024 dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione Europea e che tutti gli Stati membri dovranno recepire entro il 2 dicembre 2026. La Direttiva contiene prescrizioni minime comuni, orientate a migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali per questa tipologia di lavoratori. A tal fine prescrive agli Stati membri di garantire che i lavoratori delle piattaforme digitali dispongano di una corretta determinazione della loro situazione occupazionale e di limitare, in questo ambito, il ricorso al lavoro autonomo fittizio. Per il raggiungimento di tali finalità, il legislatore europeo promuove, per un verso, il principio del “primato dei fatti”, che – conformemente alla raccomandazione n. 198 dell’OIL sul rapporto di lavoro (2006) – impone di valorizzare le effettive modalità di esecuzione del lavoro più che la formale descrizione data dalle parti al rapporto; per altro verso, prescrive agli Stati membri di introdurre una presunzione legale (relativa) di subordinazione nei procedimenti amministrativi e giudiziari, così da riequilibrare l’asimmetria contrattuale che connota la posizione dei lavoratori rispetto alle piattaforme digitali. Ciò al fine della determinazione della corretta situazione occupazionale (art. 4 Dir. UE 2024/2831), tenendo conto della premessa natura eterogenea della categoria, che richiede la verifica caso per caso del corretto inquadramento delle modalità attraverso le quali la prestazione lavorativa è organizzata.
Alla luce di quanto premesso, nelle more del recepimento della sopra richiamata Direttiva e senza voler in alcun modo anticipare le scelte che saranno assunte in quella sede dal legislatore nazionale, appare utile provvedere ad una ricostruzione quanto più possibile puntuale delle connotazioni dei rapporti di lavoro di cui trattasi.
Le peculiari ed eterogenee modalità che connotano lo svolgimento della prestazione lavorativa dei riders si riflettono, infatti, sulle diverse tipologie di lavoro adottabili. Al pari di qualsiasi altra attività umana, anche quella prestata dai ciclofattorini può atteggiarsi sia quale prestazione di lavoro autonomo che come rapporto di lavoro subordinato (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. lav., sent. n. 2728 dell’8 febbraio 2010 e sent. n.11539 del 15 giugno 2020). Tuttavia, in considerazione delle specifiche caratteristiche di detta attività – nella quale può essere particolarmente complessa l’individuazione degli indici tipici per classificare il rapporto all’interno dell’una o dell’altra categoria contrattuale – il legislatore, con il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (convertito, con modificazioni, con la legge 2 novembre 2019, n. 128), ha novellato l’art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2015, introducendo una previsione ad hoc per le collaborazioni continuative, a carattere prevalentemente personale, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (c.d. collaborazioni etero-organizzate). In tal modo, la novella normativa, pur non inserendo nell’ordinamento un tertium genus di lavoro, ha introdotto una disposizione di carattere rimediale che – in ragione della loro sostanziale posizione di debolezza contrattuale – prevede l’applicazione delle tutele riservate al lavoro subordinato anche a quei soggetti che, per le concrete modalità di svolgimento della prestazione, continuano ad essere inquadrabili nell’ambito del lavoro autonomo (Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663). Contestualmente, è stato inserito nel medesimo decreto legislativo n. 81/2015 anche il Capo V-bis che ha dettato una disciplina speciale per il lavoro autonomo prestato attraverso piattaforme digitali, nell’ottica di garantire un nucleo minimo di tutele anche ai lavoratori che non rientrino nella categoria delle collaborazioni etero-organizzate.
L’individuazione di elementi certi per la qualificazione dell’attività lavorativa dei ciclofattorini è stata oggetto di diversi interventi giudiziali che hanno affrontato la tematica non sulla base della definizione formale del rapporto, bensì – in linea con il principio del primato dei fatti richiamato dal legislatore europeo – sulla scorta del concreto atteggiarsi dello stesso e della verifica fattuale della presenza o meno degli indici primari e sussidiari di subordinazione nei modelli organizzativi utilizzati dalle piattaforme, per valutare il grado di ingerenza delle stesse sulle modalità di svolgimento della prestazione. E ciò in coerenza con il richiamo ripetutamente effettuato dalla Corte costituzionale al principio di indisponibilità della tipologia contrattuale che impedisce non solo alle parti, ma allo stesso legislatore di ascrivere all’area dell’autonomia rapporti di lavoro caratterizzati dalla subordinazione e viceversa, posta l’inderogabilità dello statuto protettivo che alla subordinazione si accompagna (cfr. sentenze n. 121 del 1993; n. 115 del 1994 e, da ultimo, n. 76 del 7 maggio 2015, paragrafo 8 del Considerato in diritto).
Tanto considerato, la prestazione lavorativa in esame potrà atteggiarsi secondo le diverse modalità organizzative di seguito più dettagliatamente illustrate.
a. Lavoro autonomo
La possibilità che il lavoro tramite piattaforma possa essere svolto con la forma del lavoro autonomo non è soltanto un’ipotesi teorica, per assecondare l’affermazione del principio generale, di rango costituzionale, della indisponibilità del tipo contrattuale, ma è testimoniata in concreto dal corpo normativo vigente.
In tal senso, l’art. 47-bis del d.lgs. n. 81/2015, con cui si apre il capo V-bis dedicato alla tutela del lavoro tramite piattaforme digitali, nell’individuare l’alveo di operatività dei canoni di garanzia che intende apprestare alle condizioni dei lavoratori per le piattaforme digitali, opera un’esplicita indicazione circa i livelli minimi di tutela per questa particolare categoria di lavoratori, dei quali innanzi tutto è definita la natura autonoma. È il legislatore quindi, ad intravedere innanzi tutto la plausibilità, nell’ambito di un’organizzazione genuina della prestazione lavorativa, della riconduzione della fattispecie in esame al lavoro autonomo.
Così, ad esempio, potrà essere qualificata in termini di genuina autonomia, l’attività complessivamente caratterizzata:
– dall’assenza di:
– poteri di controllo, anche in relazione ai tempi e al luogo della prestazione (esercitati, ad esempio, attraverso l’imposizione di tempi di consegna o la geolocalizzazione del rider per finalità estranee a quelle, strumentali, dettate dalle esigenze organizzative dell’attività di consegna);
– poteri di direzione (quali, ad esempio, l’obbligo di presenza in determinate aree per poter accedere alla app e ricevere ordini di consegna o l’obbligo di seguire percorsi predeterminati per effettuare le consegne);
– poteri sanzionatori (quali il ranking reputazionale, ove lo stesso abbia espresse conseguenze sulla retribuzione, ad esempio, collocando l’attività in orari più o meno remunerativi a seconda della affidabilità del lavoratore o privando i lavoratori meno performanti di occasioni di lavoro, fino a disporre la loro disconnessione dall’account, presupposto necessario per svolgere ulteriori attività di consegna);
– dalla reale facoltà del prestatore di non accettare l’incarico di consegna o di dismettere la sua disponibilità in modo unilaterale, senza subire alcuna conseguenza pregiudizievole per successive collaborazioni.
Ciò che rileva, pertanto, sono le modalità concrete attraverso le quali l’attività lavorativa è resa, con la conseguente necessità di conferire adeguatezza alle condizioni dei lavoratori, anche quando l’assenza degli elementi qualificatori tipici della subordinazione consente di escludere la riconducibilità del lavoro tramite le piattaforme digitali alla disciplina dell’art. 2094 c.c. o a quella della etero-organizzazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015.
A conferma della necessità di garantire condizioni di tutela della persona a prescindere dalla qualificazione del rapporto di lavoro, anche in questi casi l’ordinamento garantisce comunque ai riders un livello di tutele compatibile con la natura autonoma della prestazione. Il Capo V-bis (artt. dal 47-bis al 47-octies) del d.lgs. n. 81/2015 – intitolato “Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali” – ha infatti riconosciuto ai “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore” il diritto, tra l’altro, a:
1. un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
2. un’indennità integrativa (pari almeno al 10% del compenso di base) per il lavoro svolto di notte, nei giorni festivi 0, comunque, in condizioni metereologiche sfavorevoli;
3. una copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con un premio assicurativo determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta nonché il rispetto della normativa prevenzionistica (d.lgs. n. 81/2008).
b. Rapporto di lavoro subordinato
La possibilità di intrattenere un rapporto di lavoro di natura subordinata per il tramite delle piattaforme digitali può essere innanzi tutto frutto di una esplicita decisione in tal senso, manifestata attraverso l’assunzione, con tutte le formalità del caso, dei ciclofattorini, da parte delle piattaforme.
Gli elementi essenziali a cui far riferimento per la qualificazione di un rapporto come subordinato, si rinvengono nell’art. 2094 c.c. che richiama gli indici della “dipendenza” e della “direzione”, da cui discende un vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con inserimento nell’organizzazione aziendale e conseguente limitazione dell’autonomia del lavoratore stesso.
Come già evidenziato, l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorrente con le piattaforme digitali deve essere compiuto in base alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, tenendo conto degli indici di subordinazione che fanno presumere un controllo nell’esecuzione del lavoro da parte delle piattaforme digitali (cfr. Corte di Cassazione 24 gennaio 2020, n. 1663).
In proposito, la più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Torino, 14 gennaio 2023, n. 1560) ha offerto utili indicazioni riguardo alla presenza di indici rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato in relazione alla peculiare attività svolta dal rider per una piattaforma digitale, declinando il concreto atteggiarsi dei poteri tipici del datore di lavoro in quest’ambito secondo modalità tali da evidenziare in modo inequivocabile la messa a disposizione da parte del rider delle proprie energie in favore dell’organizzazione imprenditoriale che si avvale della piattaforma digitale.
Così, con riferimento al potere direttivo, si è ritenuto che l’esistenza di direttive specifiche e sostanzialmente vincolanti, cui il ciclofattorino è tenuto ad attenersi nelle diverse fasi della propria attività, renda manifesta l’eterodirezione esercitata dalla piattaforma sull’attività svolta dal lavoratore, caratteristica che la distingue nettamente dall’attività di consegna svolta da un lavoratore autonomo. È quanto avviene, ad esempio, nei casi in cui, una volta ricevuto l’affidamento di un ordine, i riders sono assoggettati a puntuali indicazioni su come procedere, fornite in tempo reale tramite app, con la quale vengono trasmesse puntuali indicazioni per le modalità di svolgimento della prestazione.
Allo stesso modo è indice evidente dell’esistenza di un potere di controllo esteso e pervasivo – non concepibile in relazione ad un lavoratore autonomo a cui venga affidata una consegna – il fatto che la piattaforma informatica imponga il rispetto di predeterminati slot orari e ordini e attribuisca punteggi ai ciclofattorini, laddove al basso punteggio si accompagnino rilievi o altre conseguenze di natura sostanzialmente disciplinare. Ciò laddove il sistematico e capillare controllo da parte della piattaforma consenta, peraltro, alla società che la gestisce, di porre agevolmente in essere, a fronte della violazione delle sue indicazioni, svariate forme di reazione direttamente destinate a ricondurre il rider al comportamento corretto e del tutto assimilabili all’esercizio del potere disciplinare.
In definitiva, occorre quindi prestare particolare attenzione alle caratteristiche tecniche del funzionamento della piattaforma e dello specifico algoritmo utilizzato, che possono porre all’autonomia del lavoratore limiti tali da poter ricondurre alla piattaforma e all’algoritmo medesimi una sintesi dei tipici poteri direttivo, di controllo e disciplinare propri di un datore di lavoro nei confronti di un lavoratore subordinato.
Tra le tipologie contrattuali di lavoro subordinato presenti all’interno del nostro tessuto ordinamentale, la dinamica lavorativa in analisi appare inverare maggiormente i tratti caratterizzanti il lavoro intermittente. Ciò ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 81/2015, che con riferimento alla fattispecie del lavoro intermittente, la definisce come quella avente appunto tale carattere “o” discontinuo.
È a tale tipologia contrattuale pertanto, che, laddove richiamata dalla contrattazione collettiva e nell’ambito dei profili di legge, si potrà fare riferimento per disciplinare il rapporto in punto di trattamento economico, normativo e previdenziale, laddove richieste e ritenuta effettiva la esigenza. Sul punto, il legislatore, all’art. 17 del D.lgs n. 81/2015, stabilisce una ragionevole riparametrazione del trattamento economico, normativo e previdenziale, risultando riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.
La collocazione, in concreto, nell’alveo della fattispecie del lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, determina l’applicazione della normativa vigente in materia di orario di lavoro (decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66).
L’attrazione verso la tipologia del lavoro intermittente, inoltre, impone di porre attenzione, in punto di analisi dello specifico rapporto di lavoro, alla circostanza se sia o meno contrattualmente definito un obbligo di risposta alla chiamata, considerati i riflessi ad esso connessi quanto all’indennità di disponibilità, alle tutele previdenziali, della malattia, della genitorialità.
Il richiamo al contratto intermittente introduce il tema della indennità di disponibilità. Ferme restando le peculiarità proprie della fattispecie in esame, l’indennità in commento dovrebbe avere rilievo soltanto a quei lassi temporali in cui il rider, secondo le modalità organizzative definite dalla piattaforma, si pone effettivamente a disposizione esclusiva del committente in attesa di ricezione/accettazione dell’incarico di consegna, con un vincolo di fatto effettivo e strettamente funzionale al rendimento della prestazione.
Nella particolare ipotesi in commento, si ritiene che – qualora il lavoratore sia tenuto a rispondere alle chiamate durante il periodo di permanenza in piattaforma – il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa da retribuire, coincida con il tempo effettivamente impiegato per rendere la prestazione medesima.
Diversamente, per il periodo durante il quale al lavoratore sia richiesto il collegamento con la piattaforma e fino al momento della sua disconnessione, è riconosciuta l’indennità di disponibilità, laddove prevista dal contratto e nella misura dallo stesso stabilita. Ciò in quanto, altrimenti, nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo (art. 13, co. 4, d.lgs. 81/2015).
Naturalmente, qualora si utilizzi tale tipologia contrattuale di lavoro subordinato, occorre osservare anche gli obblighi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2015, in base al quale il contratto deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova (comma 1) e il datore di lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa intermittente o di un ciclo integrato di prestazioni intermittenti di durata non superiore a 30 giorni, è tenuto a comunicarne la durata all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente (comma 3).
c. Collaborazioni etero-organizzate
Tenuto conto del più volte richiamato principio della indisponibilità del tipo contrattuale, ai ciclofattorini può essere applicata la disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato anche quando l’attività dagli stessi svolta non sia riconducibile all’area della subordinazione, ma, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, le modalità attraverso le quali è attuata “si concretano in prestazioni di lavoro:
– prevalentemente personali,
– continuative
– e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”.
È di tutta evidenza che l’applicazione della norma in discorso non riguarda quelle modalità di organizzazione della prestazione lavorativa che, nonostante la presenza dell’elemento di novità della piattaforma digitale, configurano un rapporto di lavoro di tipo subordinato, riconducibile all’art. 2094 c.c.
È poi lo stesso art. 47-bis ad escludere dall’ambito applicativo del Capo V bis le prestazioni che configurano una collaborazione etero-organizzata, giusto il rinvio all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015.
La norma, come premesso, non esclude la genuinità della natura c.d. para-subordinata della prestazione di lavoro. Tuttavia, quando alla natura prevalentemente personale della prestazione si aggiunge un rilevante momento organizzativo che promani dal committente, il legislatore ha reputato la necessità di ricondurre quelle fattispecie sotto l’egida dell’art. 2094 c.c., ritenendo l’applicazione di quella disciplina ad esclusivi fini di tutela delle condizioni di ritenuta oggettiva debolezza contrattuale, senza che consegua la riqualificazione della natura del rapporto di lavoro.
Personalità, continuità ed etero organizzazione sono, quindi, considerate dall’ordinamento indicative di una condizione lavorativa di particolare dipendenza economica e debolezza contrattuale che spiega la scelta di proteggere il lavoratore attraverso l’applicazione della disciplina della subordinazione, prescindendo dal formale inquadramento del rapporto come subordinato, in una prospettiva che assume un carattere sostanzialmente rimediale e antielusivo. In tal senso, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1663 del 2020, ha affermato che la ratio dell’art. 2, comma 1, è da rinvenirsi nella scelta politico legislativa di «assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoro subordinato […], al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di “debolezza” economica, operanti in una “zona grigia” tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea».
L’assimilazione delle tutele – ivi comprese quelle connesse alla disciplina dell’orario di lavoro – si giustifica, dunque, in ragione dell’esistenza di un vincolo di coordinamento esterno e unilateralmente imposto dal committente al lavoratore che, per svolgere la prestazione, è obbligato ad adeguarsi all’organizzazione del primo.
d. Profili previdenziali
Per quanto concerne i profili relativi all’inquadramento previdenziale dei lavoratori in questione, va fatto necessariamente riferimento al noto e consolidato principio del parallelismo e automatismo tra l’applicazione della disciplina lavoristica e quella previdenziale (cfr. ad es. Cassazione Sentenza n. 5097 del 11/10/1984), secondo il quale “la relazione di lavoro è il presupposto che giustifica l’insorgenza del rapporto giuridico, che, una volta qualificato, con individuazione della sua disciplina giuridica, determina, in conseguenza, quella previdenziale” (Tribunale di Milano, sentenza n. 3237 del 19.10.2023).
Pertanto, definita per i rapporti di lavoro di cui alle precedenti lettere b) e c) l’applicazione della disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato, ne consegue il loro inquadramento previdenziale con obbligo di iscrizione nell’AGO dell’INPS (“Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti”).
In particolare, il richiamo dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 81/2015, laddove fa riferimento all’applicazione della “disciplina del rapporto di lavoro subordinato”, concepisce tale rinvio nella sua interezza e non si rintracciano motivi per escludere da tale applicazione la disciplina di tipo previdenziale.
e. Profili prevenzionali e assicurativi ai fini INAIL
Alla luce di quanto sin qui riassunto, appaiono confermate le diverse modalità attraverso le quali può essere validamente regolata l’attività dei ciclofattorini che operano tramite piattaforma, realizzando tutele differenziate in conformità alla tipologia del rapporto. Tanto ad eccezione dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Testo Unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, infatti, la tutela è identica sia che si tratti di lavoratori subordinati, che di collaboratori eterodiretti a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, che di lavoratori autonomi.
L’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato in presenza di rapporti di lavoro autonomo non genuini ha effetto esclusivamente ai fini dell’imponibile retributivo da assumere per la determinazione dei premi assicurativi dovuti dall’impresa titolare della piattaforma digitale definita “committente” che, per espressa previsione di legge, è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Infatti, in caso di applicazione della disciplina del lavoro subordinato, il datore di lavoro dovrà versare i premi assicurativi anziché sulla retribuzione convenzionale prevista dall’art. 47-septies per i lavoratori autonomi, su quella effettiva o, comunque, su quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o dal CCNL da assumere.
f. Cenni sulla direttiva UE 2024/2831
Fermo restando quanto rappresentato in premessa in ordine alla volontà di non anticipare i contenuti del recepimento della direttiva UE 2024/2831, si evidenzia che, a prescindere dalla classificazione del lavoro dei ciclo-fattorini come subordinato, autonomo o etero-organizzato, dalla stessa derivano indicazioni in merito, tra l’altro alla gestione algoritmica dei rapporti di lavoro.
In raccordo con la disciplina posta dal regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, è necessario prevedere innanzitutto l’obbligo per le piattaforme di lavoro digitali di informare le persone che svolgono un lavoro per il loro tramite, i rappresentanti dei lavoratori, nonché, su richiesta, le autorità nazionali competenti, in merito all’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati per monitorare, supervisionare o valutare l’esecuzione del lavoro, nonché per prendere o sostenere decisioni che incidano sulle condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali (art. 9), tra cui “i motivi alla base delle decisioni di limitare, sospendere o chiudere l’account della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali o di non retribuire il lavoro svolto dalla stessa, nonché delle decisioni in merito alla sua situazione contrattuale o di qualsiasi decisione con effetto equivalente o pregiudizievole” (art. 9, par. 1, lett. b), punto IV).
La direttiva prevede poi una supervisione umana ed una valutazione periodica, almeno biennale, con la partecipazione delle rappresentanze dei lavoratori, dell’impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, incluso, laddove applicabile, sulle loro condizioni di lavoro e sulla parità di trattamento sul lavoro (art. 10, par. 1).
Le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali hanno, altresì, diritto di ottenere, senza indebito ritardo, una spiegazione da parte delle piattaforme digitali in merito alle decisioni prese o sostenute da un sistema decisionale automatizzato, incluse quelle di limitare, sospendere o risolvere il rapporto contrattuale o chiudere l’account del lavoratore; decisioni queste che devono essere prese necessariamente da un essere umano (art. 10, par. 5). In particolare, ai lavoratori delle piattaforme digitali deve essere garantita la possibilità di rivolgersi ad una persona di contatto designata dalla piattaforma di lavoro digitale per discutere e chiarire i fatti, le circostanze e i motivi di tale decisione (art. 11, par. 1), con diritto, qualora la spiegazione non sia soddisfacente o si ritengano violati i propri diritti, di chiedere un riesame. “Qualora la decisione… violi i diritti di una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, la piattaforma di lavoro digitale rettifica tale decisione senza ritardo e in ogni caso entro due settimane dall’adozione della decisione. Qualora tale rettifica non sia possibile, la piattaforma di lavoro digitale offre un adeguato risarcimento del danno subito. In ogni caso, la piattaforma di lavoro digitale adotta le misure necessarie, compresa, se del caso, la modifica del sistema decisionale automatizzato o la cessazione del suo utilizzo, al fine di evitare tali decisioni in futuro” (art. 11, par. 3).
Da richiamare infine le disposizioni della direttiva UE in tema di informazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, con possibilità del ricorso ad esperti nonché di promozione della contrattazione collettiva.
Sul piano della tutela collettiva, fermo restando il quadro generale in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, si richiede alle piattaforme di lavoro digitale di informare e consultare in via prioritaria i rappresentanti dei lavoratori (“quali i sindacati e i rappresentanti liberamente eletti dai lavoratori delle piattaforme digitali conformemente al diritto e alle prassi nazionali”, cfr. art. 2, par. 1, lett. f) o, in loro mancanza, i lavoratori stessi, anche sulle “decisioni che possono comportare l’introduzione di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati o modifiche sostanziali al loro utilizzo” (art. 13, par. 2).
Alla valorizzazione della contrattazione collettiva risponde la previsione che prevede l’impegno da parte degli Stati membri di promuovere il ruolo delle parti sociali e incoraggiare l’esercizio della contrattazione collettiva nel lavoro mediante piattaforme digitali, “comprese misure relative alla determinazione della corretta situazione occupazionale dei lavoratori delle piattaforme digitali e ad agevolare l’esercizio dei loro diritti relativi alla gestione algoritmica…” (art. 25).
È da ritenere che la contrattazione collettiva possa intervenire a regolare non solo i rapporti di lavoro subordinato, ma anche quelli di lavoro autonomo”
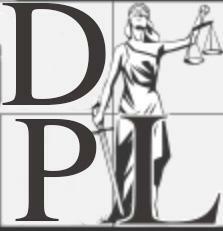
Commenti recenti