Corte dei conti. Sezioni riunite in sede di controllo. Audizione nell’ambito della “indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea”. Commissioni bilancio congiunte del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
Maggio 2024
“[…] 5. Conclusioni. La valutazione della Corte sulla riforma della governance economica dell’UE è complessivamente positiva. È condivisibile la scelta di concentrare la sorveglianza sulla dinamica “di fondo” del rapporto debito/Pil attraverso il controllo di un unico strumento operativo: la spesa netta. Un aggregato per il quale sarà, quindi, necessaria una sempre migliore programmazione ed un attento monitoraggio. Va apprezzato l’approccio unitario richiesto dal nuovo framework a ciascun Paese: integrare progetti di riforme e investimento con obiettivi macroeconomici e di bilancio e perseguire il conseguimento di tutti i target tramite l’attuazione di un coerente Piano strutturale di bilancio. Tuttavia, se i passi avanti sono indubbi – dalla prospettiva pluriennale dell’aggiustamento alla sua maggiore correlazione con le specificità dei singoli Paesi – sugli esiti finali della riforma ha pesato il diverso approccio tra gli Stati. Le revisioni apportate al disegno originario non appaiono sempre coerenti con la logica di fondo (la sostenibilità del debito) e alcune delle clausole di salvaguardia (riduzione annua minima del rapporto debito/Pil, margine di resilienza del deficit, ecc.) irrigidiscono l’architettura e rischiano di impedire il conseguimento di obiettivi come la semplificazione e il contrasto della pro-ciclicità.
Come emerge dalle stime del DEF 2024, per l’Italia la concreta attuazione della riforma richiederà sforzi significativi, specie dopo la fase 2025-2027, connotata da elementi di transitorietà. L’auspicio è che a livello europeo cresca, nei prossimi anni, la consapevolezza che la governance economica dell’UE dovrà anche contribuire a rispondere alle difficili sfide connesse alle crisi in atto (climatica, energetica, geopolitica, ecc.) e alle relative implicazioni in termini di maggiori investimenti per la produzione di beni pubblici europei. Per il pieno successo del processo riformatore è ora necessaria un’adeguata traslazione delle nuove regole negli ordinamenti nazionali. È confermata, ad avviso della Corte, la coerenza costituzionale del nuovo quadro di regole: l’equilibrio tra entrate e spese al cui presidio è finalizzata la normativa interna, deriva infatti automaticamente da una variazione della spesa calcolata tenendo conto (tra l’altro) della manovra discrezionale sull’entrata.
Quanto alla struttura e alla tempistica dei documenti programmatici di bilancio, l’esito della nuova procedura potrebbe non risolversi necessariamente nel superamento dell’attuale assetto dei documenti contabili annuali e delle relative scadenze. Rimane uno spazio di azione, comunque, per la revisione dei “tendenziali” nonché per l’aggiustamento dell’agenda interna al fine di mantenersi in linea con il Piano in riferimento sia al quomodo sia all’aggiornamento alla luce delle numerose variabili in gioco. Sarà necessario, invece intervenire sui testi delle leggi nn. 243 e 196, ed in particolare soprattutto sul Capo II della prima che appare destinatario di una opera di revisione, mentre, al suo interno, l’art. 6, riferito agli scostamenti per eventi eccezionali, al di là dell’aggiornamento dei richiami ai nuovi istituti, risulta confermato. Con il nuovo approccio della governance europea, incentrato sull’indicatore di spesa netta, sarà necessario ridisegnare il coinvolgimento delle autonomie territoriali. Per le regioni e gli enti sanitari, i margini per introdurre tetti alla spesa sono limitati.
Il rilievo della spesa sanitaria e il meccanismo attuale di copertura con nuove entrate a fronte di eventuali eccedenze di spesa rispetto ai fabbisogni standard rappresenta una salvaguardia sufficiente, da rafforzare semmai per quella non sanitaria. Per gli enti locali, che sostengono la maggior parte della spesa territoriale, è necessario introdurre regole di contenimento; fondamentale sarà trovare un equilibrio tra il contributo alla finanza pubblica e le prerogative costituzionali delle autonomie territoriali, ma anche evitare una compressione della spesa produttiva, come gli investimenti e un eccessivo tecnicismo e complessità delle regole, che renderebbero difficile la programmazione di bilancio delle amministrazioni locali. Il contributo può muovere da quanto previsto nella legge di bilancio per il 2024, ma è anche urgente risolvere i nodi legati alla mancata piena attuazione del federalismo fiscale. Una regola che deve bilanciare il controllo della spesa pubblica con lo sviluppo economico e la garanzia dei diritti dei cittadini su tutto il territorio.
Quanto alle tecniche relative alle procedure parlamentari e ai parametri per le coperture finanziarie, si può sostenere una linea di continuità tra il precedente assetto e quello ora subentrato. Anche in questa occasione la Corte non può che raccomandare un utilizzo della procedura per gli eventi eccezionali, attento a garantire il rispetto del vincolo costituzionale tra straordinarietà della copertura a debito ed eccezionalità della natura dell’intervento. Per quanto riguarda gli altri temi, fondamentale è una maggiore considerazione della cd. “legislazione vigente” in sede previsionale, per questioni di trasparenza ed anche perché le relative quantificazioni rappresentano in larga parte il frutto di stime, che in quanto tali ben possono fare ingresso nel dibattito parlamentare. Dall’altro lato, sarebbe auspicabile una maggiore enfasi sull’esame del rendiconto quale sede di riscontro dell’operato del Governo.
In tale contesto, una maggiore attenzione dovrebbe essere posta sul collegamento tra titolo giuridico e relativa quota di stanziamento di spesa, da rendere compiutamente ricostruibile. In riferimento anzitutto alla trasparenza circa i criteri di costruzione delle singole poste, sarà da approfondire l’impatto sulla gestione del cd. impegno pluriennale ad esigibilità (IPE) per la spesa e l’accertamento qualificato per l’entrata.
A giudizio della Corte incontrerebbe problemi di legittimità, peraltro, nell’attuale quadro istituzionale, una norma che consentisse una gestione amministrativa delle risorse difforme rispetto al dato legislativo “a monte”.
Nell’approccio alla contabilità economico-patrimoniale (accrual) è necessaria una grande prudenza: non va dimenticato, infatti, che il momento e le modalità della previsione, gestione e rendicontazione delle risorse della collettività mettono a fuoco il punto di sintesi nel quale viene a correlarsi la raccolta coattiva delle risorse in entrata alle uscite dell’operatore-pubblico quale frutto di scelte discrezionali in vista del soddisfacimento delle esigenze della collettività medesima: è a tali esigenze che sembra meglio rispondere l’attuale contabilità finanziaria.
Quanto, infine, alla spending review, il processo di revisione della spesa nel nostro ordinamento non può che passare per l’adozione dello strumento della legislazione primaria al fine di ricomporre il quadro dei servizi che l’operatore pubblico eroga alla collettività in base a chiare scelte discrezionali non di corto respiro, ma tali da incidere sul tessuto normativo che prevede spesa, caratterizzato formalmente da grande rigidità. La Corte, in conclusione, a fronte di un così ampio ed articolato percorso di riforma dell’ordinamento contabile interno, conferma naturalmente la piena disponibilità ad offrire il proprio apporto tecnico nelle diverse sedi in ordine alla definizione di così rilevanti istituti”.
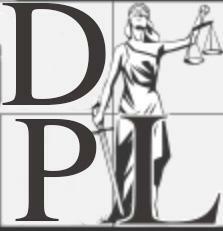
Commenti recenti